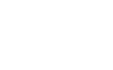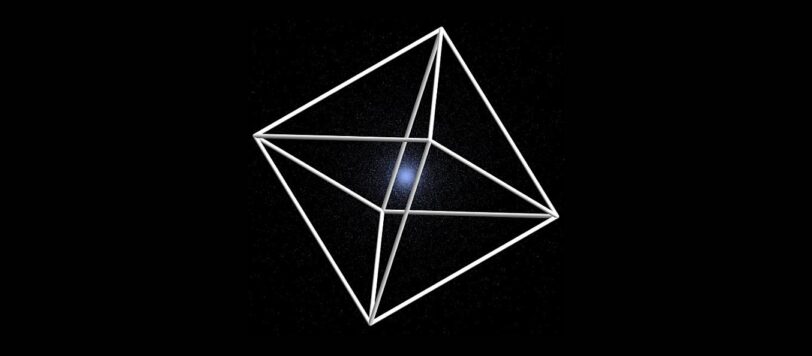
*Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta*
Diaspora, il crepuscolo della Terra nell’eco delle onde gravitazionali 💫
E se una collisione di stelle di neutroni avvenisse nel nostro vicinato galattico?
COUNTDOWN VERSO APRILE 2026, IL CENTENARIO DELLA FANTASCIENZA: -8
“All’una del pomeriggio, le onde gravitazionali di Lacerta avevano raggiunto un’intensità pari a cento volte quella abituale. Era inutile aspettare che arrivassero i dati degli ultimi rilevatori del sistema TERAGO, per eliminare le interferenze da altre fonti; l’informazione arrivava direttamente dal cratere di Bullialdus in tempo reale e l’impulso di Lac G-1, sempre più rapido, era abbastanza forte per coprire ogni altra fonte gravitazionale celeste. Le onde si stavano visibilmente “accorciando”, ciascuna era chiaramente più stretta della precedente, e gli ultimi due picchi erano a solo 15 minuti di distanza, dato che indicava come le stelle di neutroni avessero oltrepassato il contrassegno dei duecentomila chilometri. In un’ora la distanza si sarebbe ridotta alla metà, poi, in pochi minuti, si sarebbe annullata. Yatima aveva continuato a sperare che quella dinamica subisse un rallentamento, ma le estrapolazioni dei gleisner, sempre più ripide, si stavano dimostrando giuste.”
Il romanzo Diaspora dello scrittore australiano Greg Egan, originariamente pubblicato nel 1997 e poi uscito nel 2003 in Italia nella collana Urania con la traduzione del bravissimo Riccardo Valla, è una delle opere più ambiziose e radicali della fantascienza hard, una narrazione che combina rigore scientifico e speculazione filosofica in un complesso futuro post-umano. Nell’opera si immagina un’umanità frammentata in tre filoni evolutivi distinti: i carnei, esseri ancora legati ai corpi biologici tradizionali oppure geneticamente modificati; i gleisner, menti trasferite in corpi robotici mobili; e i cittadini delle polis, città virtuali che ospitano intelligenze disincarnate come Yatima, il protagonista, una coscienza artificiale nata spontaneamente da mutazioni casuali introdotte in un genoma digitale esistente. Per gli abitanti delle polis la scienza è un’esperienza immersiva vissuta in prima persona: essi non si limitano a formulare teorie fisiche, giacché entrano letteralmente all’interno dei modelli matematici che costruiscono, percependo lo spazio-tempo e le dimensioni extra come se fossero paesaggi reali. In questo modo, la conoscenza dell’universo diventa parte integrante della loro identità.
Tuttavia, le stime delle intelligenze artificiali, fondate su una comprensione ancora incompleta dei meccanismi gravitazionali in regime estremo, si rivelano tragicamente errate quando, nel 2996, un evento tanto catastrofico quanto inatteso sconvolge la Terra: il sistema binario di stelle di neutroni Lac G-1, situato a circa 100 anni luce di distanza nella costellazione della Lucertola (il cui nome ufficiale è Lacerta, in latino), collassa in un’unica stella ipermassiva milioni di anni prima del previsto. Ad accompagnare la fusione è il rilascio di un lampo di raggi gamma così potente da spazzare via l’ozono presente nella stratosfera e da devastare l’intero ecosistema terrestre, segnando l’inizio di una crisi senza precedenti. Utilizzando TERAGO, l’osservatorio lunare progettato per rilevare onde gravitazionali con la massima precisione, il gleisner Karpal riesce a registrare l’evento in tempo reale e a prevederne le terribili conseguenze per i carnei terrestri, ma troppo tardi per intervenire e prepararsi. Egan scrive a tal proposito che, nella fase di coalescenza delle due stelle di neutroni, vengono sprigionate onde gravitazionali di frequenza e intensità crescenti, fino al raggiungimento del picco al momento della fusione, coerentemente con quanto oggi si conosce grazie a rilevatori reali come LIGO, Virgo e KAGRA.
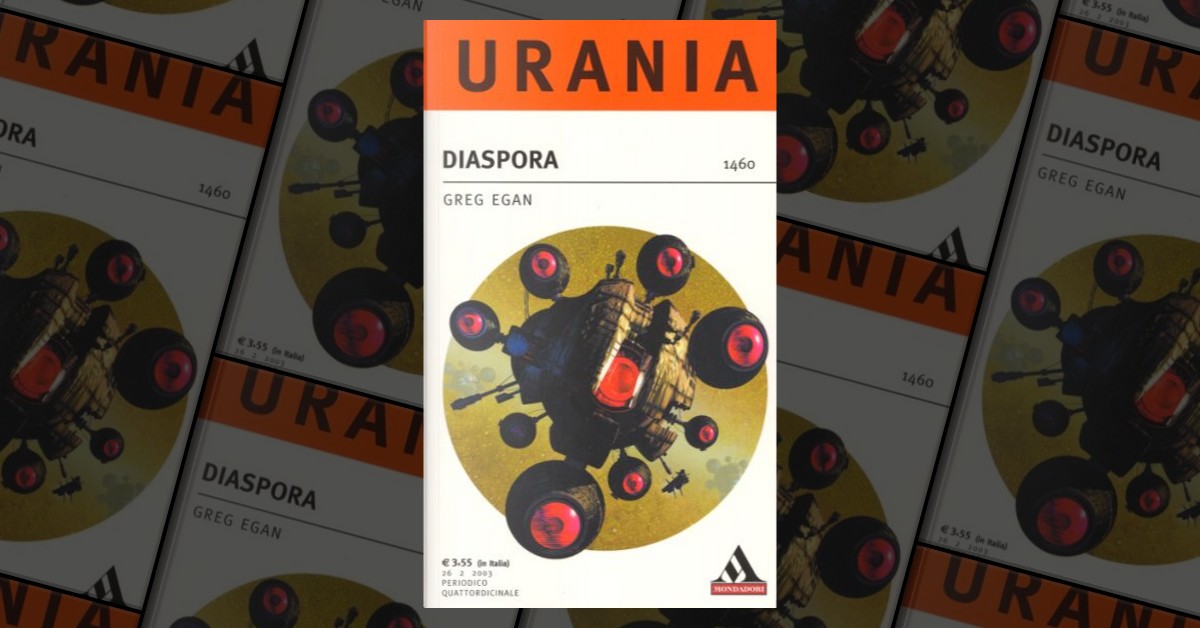
In base alla teoria della relatività generale di Albert Einstein, le onde gravitazionali sono “increspature” dello spazio-tempo — il “tessuto” che permea l’universo e che può deformarsi sotto l’influenza di massa ed energia —, cioè perturbazioni che, viaggiando alla velocità della luce, lo comprimono e distendono al loro passaggio. Esse sono prodotte dalla fusione di oggetti compatti, ovvero corpi enormemente massivi e densi come stelle di neutroni o buchi neri, in sistemi binari stretti, cioè in cui la separazione tra le due componenti è molto piccola. Senza entrare in eccessivi tecnicismi, affinché un sistema binario di oggetti compatti emetta onde gravitazionali, è necessario che la sua distribuzione di massa complessiva sia asimmetrica, che il momento d’inerzia totale non si conservi e che il moto rotatorio delle sue componenti sia accelerato: in pratica, i due corpi devono ruotare in maniera non perfettamente simmetrica rispetto al comune centro di massa, con un movimento che accelera e modifica continuamente la distribuzione di massa nel sistema.
L’evoluzione di un sistema binario compatto può essere suddivisa idealmente in tre fasi, dette inspiral, merger e ringdown. Durante la fase di inspiral, le due componenti spiraleggiano lentamente l’una verso l’altra man mano che perdono energia sotto forma di onde gravitazionali. Questo processo provoca un graduale decadimento orbitale e mentre l’orbita si restringe, la velocità orbitale aumenta, e così anche la frequenza e l’ampiezza del segnale gravitazionale. La frequenza di emissione tipica va da una decina a qualche centinaio di hertz e il suo valore esatto dipende dalla frequenza orbitale del sistema binario, ovvero da quanto velocemente i due oggetti orbitano attorno al centro di massa: più sono vicini e rapidi, maggiore sarà il numero di oscillazioni da essi generato che attraversa lo spazio-tempo in un secondo. Il segnale gravitazionale acquista perciò un profilo caratteristico chiamato chirp, poiché il suono che ne risulta ha l’andamento crescente in frequenza tipico di un cinguettio (appunto “chirp” in inglese). Per descrivere matematicamente l’inspiral si usano le approssimazioni post-newtoniane, una serie di correzioni alle equazioni della fisica classica che introducono progressivamente gli effetti relativistici nella dinamica del sistema.
La situazione cambia drasticamente nella fase di merger, quando i due corpi vengono in contatto per poi fondersi. Si tratta di un regime fortemente non lineare, in cui le approssimazioni post-newtoniane falliscono e le equazioni di campo di Einstein devono essere risolte numericamente mediante simulazioni idrodinamiche. Tale fase segna il momento di massima emissione di onde gravitazionali e produce un picco nell’ampiezza del segnale, esattamente come descritto da Egan. In particolare, nella materia espulsa a seguito del merger di stelle di neutroni ha luogo il processo r (chiamato così perché implica la cattura rapida di neutroni da parte dei nuclei atomici), che promuove la sintesi di elementi pesanti quali oro, platino e uranio. Il decadimento radioattivo dei nuclei di questi elementi dà origine a una kilonova, con un forte un bagliore termico visibile in particolare nell’infrarosso e nell’ottico. Altri fenomeni di natura elettromagnetica, associati alla fusione delle stelle di neutroni binarie e indotti dall’amplificazione dei loro campi magnetici fino all’intensità di 1016–1017 Gauss, sono i getti relativistici e i lampi brevi di raggi gamma.

A seconda della massa totale e del tipo di stelle del sistema, l’esito della fusione può essere un buco nero circondato da un disco di accrescimento caldo e denso, o una stella di neutroni ipermassiva e instabile, che può collassare dopo pochi millisecondi in un buco nero oppure persistere più a lungo continuando a irradiare onde gravitazionali a frequenza quasi costante. Nello specifico, se la somma delle masse delle due stelle di neutroni supera la soglia critica di circa 2,5-3 masse solari (tenendo conto che la massa di una singola stella di neutroni è 1,2-2,3 masse solari), la formazione di un buco nero è inevitabile e il sistema entra nella fase di ringdown, dominata da un insieme di oscillazioni decrescenti esponenzialmente proprie del neonato buco nero, dette modi quasi-normali.
Le onde gravitazionali emesse durante tutte queste fasi contengono informazioni preziose sui parametri fisici degli oggetti coinvolti, tra cui massa, spin (cioè il momento angolare intrinseco), distanza, inclinazione orbitale e, nel caso delle stelle di neutroni, persino sulla loro struttura interna.
La rivelazione dei segnali gravitazionali è un’operazione che comporta notevoli difficoltà tecniche. A tal fine, gli interferometri come LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) negli Stati Uniti, Virgo in Italia e KAGRA (Kamioka Gravitational Wave Detector) in Giappone utilizzano fasci laser che percorrono due bracci perpendicolari lunghi chilometri. Le onde gravitazionali ne modificano impercettibilmente la lunghezza, cambiando lo sfasamento tra i due fasci. Tali variazioni sono dell’ordine di 10–21 m, e richiedono isolamento sismico, controllo termico e condizioni di vuoto spinto per essere misurate con precisione, senza disturbi da parte del rumore di fondo. LIGO, con due strutture gemelle situate a Livingston, nello stato della Louisiana, e a Hanford, nello stato di Washington, ha condotto tre campagne osservative: O1 dal settembre 2015 al gennaio 2016, O2 dal novembre 2016 all’agosto 2017, O3 dall’aprile 2019 al marzo 2020, mentre O4 è partita a giugno 2025 e giungerà fino a novembre. A partire dalla run O2, LIGO ha lavorato in sinergia con Virgo, l’interferometro europeo ubicato nei pressi di Pisa. Questa collaborazione ha permesso una migliore localizzazione delle sorgenti di onde gravitazionali grazie alla triangolazione dei segnali captati simultaneamente in località diverse sulla Terra.
La prima ricezione diretta di onde gravitazionali risale al settembre del 2015, con l’avvio della run O1. L’evento, denominato GW150914, ha visto due buchi neri, di circa 36 e 29 masse solari, fondersi in un buco nero finale di circa 62 masse solari. Nell’agosto del 2017, quasi al termine della run O2, invece, LIGO e Virgo hanno registrato GW170817, la prima fusione osservata di due stelle di neutroni. GW170817, individuato inizialmente tramite onde gravitazionali e successivamente associato al lampo di raggi gamma breve GRB 170817A e a segnali elettromagnetici in tutto lo spettro (dai raggi X alle onde radio), ha inaugurato l’era dell’astronomia multimessaggera. Ciò ha permesso anche di individuare la posizione della sorgente nella galassia NGC 4993, a oltre 140 milioni di anni luce di distanza.
Nel 2020, l’attivazione dell’interferometro giapponese KAGRA, costruito in un laboratorio sotterraneo nel distretto di Kamioka e dotato di specchi raffreddati criogenicamente, ha dato un importante contributo alla run O3. Infatti, la rete LIGO-Virgo-KAGRA è stata in grado di identificare un gran numero di merger di oggetti compatti con elevata affidabilità.

I futuri progetti per la rivelazione di onde gravitazionali includono l’Einstein Telescope e il Cosmic Explorer, interferometri terrestri, il primo europeo e il secondo statunitense, che avranno il compito di osservare sorgenti a redshift molto alti e di testare la relatività generale e la cosmologia. A questi si affiancherà LISA (Laser Interferometer Space Antenna), un interferometro spaziale delle agenzie ESA e NASA, che consentirà di indagare ancora più in dettaglio l’universo gravitazionale primordiale. Il nostro ricercatore Matteo Calabrese è coinvolto in studi preparatori per la missione LISA.
Pur non sapendo con certezza quali sarebbero i suoi effetti a livello globale, si può ragionevolmente assumere che un’onda gravitazionale proveniente da 100 anni luce dalla Terra non avrebbe conseguenze disastrose sull’equilibrio climatico o geologico planetario, dal momento che le interazioni con la materia sarebbero trascurabili e la deformazione prodotta sullo spazio-tempo circostante così piccola da risultare rilevabile solo da interferometri sensibilissimi. Al contrario, un lampo di raggi gamma alla stessa distanza potrebbe causare danni irreparabili, perché emetterebbe una quantità di energia approssimativamente pari a 1050 erg, vale a dire circa 108 volte quella annuale del Sole, ma concentrata in un cono spazialmente stretto e rilasciata nell’arco di pochi secondi. Qualora si trovasse nella direzione del getto, come ipotizzato da Egan in Diaspora, la Terra verrebbe investita per intero dai raggi gamma, che ionizzerebbero la stratosfera distruggendo la quasi totalità dell’ozono presente. Ciò comporterebbe l’immediata penetrazione della radiazione ultravioletta solare, estremamente nociva per il DNA e gli organismi biologici, dalla quale l’ozono funge da schermo: in mancanza di tale filtro naturale, la Terra diverrebbe inabitabile per gli esseri viventi. Soltanto le intelligenze virtuali e disincarnate delle polis potrebbero resistere, in quanto prive di corpo fisico e isolate dal mondo esterno, col quale si interfacciano esclusivamente a livello digitale.
Le onde gravitazionali sono messaggeri silenziosi di cataclismi remoti. Nondimeno, se uno di questi avvenisse ad “appena” 100 anni luce da noi, tale silenzio potrebbe diventare assordante: basterebbero invero pochi raggi gamma ben collimati per estinguere completamente la vita come la conosciamo. Fortunatamente, tale rischio è scongiurato dal fatto che nessun sistema binario di oggetti compatti è stato a oggi osservato nel vicinato terrestre, benché non si escluda che alcune delle estinzioni di massa avvenute nel passato profondo della Terra possano essere collegate a eventi di questo tipo. Il confronto tra i dati osservativi di eventi come GW170817 e le congetture elaborate da Egan in Diaspora mette dunque in luce il potere della letteratura fantascientifica di anticipare scenari non ancora realizzati, eppure fisicamente attendibili. È in questo spazio di possibilità, tra i calcoli e l’immaginazione, che si coltiva la speranza di scoperte capaci di rivoluzionare la nostra visione del cosmo.
Nus, 2 agosto 2025 – articolo aggiornato al 9 agosto 2025
Astroglossario
m: metri
s: secondi
hz: hertz, unità di misura della frequenza
G: gauss, unità di misura del campo magnetico nel sistema CGS, corrispondente a 10-4 T, simbolo del tesla
erg: unità di misura dell’energia nel sistema CGS, corrispondente a 10-7 J, simbolo del joule
anno luce: distanza percorsa dalla luce in un anno nel vuoto, corrispondente a 9,46 × 1012 km
massa solare: massa del sole, corrispondente a 1,9885 × 1030 kg
Riferimenti bibliografici
Greg Egan, Diaspora, traduzione di Riccardo Valle, Urania n. 1460, Edizioni Mondadori, 2003
Internet Speculative Fiction Database: Greg Egan, Diaspora, tutte le edizioni
Comunicato congiunto ASI INAF INFN, “Una nuova era per l’osservazione dell’universo”, 2017
NASA Scientific Visualization Studio, “Doomed Neutron Stars Create Blast of Light and Gravitational Waves”, 2017; video disponibile anche su YouTube
Aaron Gronstal, “How deadly would a nearby gamma-ray burst be?”, Astrobiology at NASA
👉 Clicca qui per leggere le altre puntate della rubrica Astronomia da fantascienza, a cura di Camilla Pianta