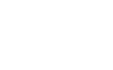*News*
NOTA CONGIUNTA SULLA SMT
Institut Agricole Régional e Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS


Negli ultimi mesi in Valle d’Aosta si è svolta una discussione aperta riguardo alla sperimentazione condotta da un centro regionale pubblico, nonché da privati, per l’applicazione alle coltivazioni della “tecnologia supra molecolare”, in sigla SMT, commercializzata da un’azienda piemontese specializzata nella produzione di “acqua informata” o “funzionale” o “stabilizzata”. Dopo un articolo di Paolo Ciambi comparso a marzo su Gazzetta Matin, la notizia è stata ripresa da vari media anche con risonanza nazionale, in particolare grazie all’analisi approfondita compiuta da Enrico Bucci, biologo e studioso di livello internazionale nel campo dell’integrità della ricerca. A giugno, in seguito a un’interpellanza in Consiglio regionale, l’Assessorato all’agricoltura e alle risorse naturali ha comunicato che non intende essere coinvolto in ulteriori sperimentazioni con la SMT. A luglio l’Institut Agricole Régional ha emesso una nota stampa in cui ha espresso una netta distanza dalla SMT, definita senza mezzi termini “bufala”.
La Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS, ente gestore dell’Osservatorio Astronomico della Regione Autonoma Valle d’Aosta e del Planetario di Lignan, da oltre vent’anni persegue per statuto l’obiettivo di diffondere la “cultura scientifica”. Ciò vuol dire che, oltre alle conoscenze, ci impegniamo anche per illustrare le modalità con cui sono ottenute, ovvero il “metodo scientifico”. Rispetto a quanto già espresso sulla sperimentazione della SMT, proprio in virtù della nostra posizione esterna alla vicenda, in accordo con l’Institut Agricole Régional vogliamo condividere una considerazione di metodo che mettiamo a disposizione della comunità e della cittadinanza, nel rispetto delle nostre finalità statutarie.
Quando un gruppo di ricerca intende attivare un progetto, presenta alla comunità di studiose e studiosi un dossier completo che spiega: lo stato dell’arte del campo, ovvero le conoscenze pregresse; l’obiettivo che si può raggiungere, ovvero le nuove conoscenze; il dettaglio del percorso da compiere per il raggiungimento dell’obiettivo, con particolare attenzione ai problemi che si possono incontrare e le soluzioni proposte per risolverli. Spetta poi alla comunità compiere le valutazioni, libere e indipendenti, per comprendere se la proposta è valida. Le conoscenze pregresse forniscono una solida base teorica al progetto? L’obiettivo è realisticamente raggiungibile? Sono stati individuati tutti i punti deboli del percorso e implementati i relativi accorgimenti per far sì che l’esito che si otterrà sia affidabile?
Il processo appena descritto seleziona i progetti che sanno mostrare in modo documentato, con rigore e trasparenza, di essere in grado di dare risultati significativi. La selezione è una necessità, perché le risorse a disposizione sono limitate. Il processo è chiamato “revisione tra pari”, perché nessuno si pone in una posizione di superiorità: è la natura che detta le regole del gioco. Ogni critica è finalizzata a ricevere una risposta costruttiva, stimolando il gruppo di lavoro a migliorare la propria proposta progettuale. Si tratta infine di un processo trasversale: ogni disciplina scientifica ha le sue specificità e declinazioni, ma il metodo scientifico è uno.
Quindi è normale e doveroso che i progetti del nostro centro di ricerca e cultura scientifica siano continuamente sottoposti a esami da parte di revisori indipendenti; diversi membri del nostro staff sono a loro volta chiamati a svolgere questo delicato ruolo per riviste specializzate e enti finanziatori, nei campi di nostra maggiore competenza. La fisica è uno di questi, in particolare l’interazione tra materia ed energia, anche a livello microscopico. A questi processi dobbiamo proprio le emissioni dei corpi celesti, a cominciare dalla luce delle stelle, che attraversa lo spazio e ci permette di studiare gli astri.
Secondo il sito dell’azienda che commercializza la tecnologia e il lavoro scientifico di riferimento (DOI: 10.14294/WATER.2022.S6), la SMT utilizza un particolare apparato per esporre l’acqua a onde con caratteristiche predeterminate. Le molecole d’acqua registrerebbero le informazioni trasmesse dalle onde, comportandosi poi in modo analogo a un’altra sostanza per un periodo prolungato. Usiamo il condizionale perché, dal punto di vista della fisica, le basi teoriche e i protocolli sperimentali descritti sono palesemente insufficienti per sostenere l’efficacia della SMT, anzi per dimostrare l’esistenza stessa del fenomeno che produrrebbe.
Basti notare come nella sezione dedicata a materiali e metodi si passi dalle onde elettromagnetiche (onde trasversali che propagano anche attraverso il vuoto, come la luce) agli ultrasuoni, cioè onde acustiche (onde longitudinali che propagano solo in presenza di un mezzo intermedio, come il suono), senza esplicitare in che modo siano connesse; si raccomanda di usare campi elettromagnetici di “bassa frequenza”, senza alcuna quantificazione (anche generica, per evitare legittime questioni di proprietà intellettuale). Nei materiali supplementari si dichiara che la SMT si basa sugli studi delle proprietà diamagnetiche delle molecole d’acqua e la loro conseguente aggregazione in macromolecole, che avrebbero meritato a Linus Pauling il premio Nobel per la fisica. In realtà al ricercatore statunitense è stato assegnato nel 1954 il Nobel per la chimica per i suoi studi sulla natura dei legami tra atomi, da cui è possibile ricostruire la struttura delle sostanze complesse. Allora su che cosa si basa la SMT?
Non si tratta di errori di distrazione, ma di oggettiva mancanza dei requisiti minimi di rigore e trasparenza per sottoporre una domanda progettuale. Non si tratta di escludere visioni eterodosse, ma della necessità di avere un retroterra culturale condiviso per permettere un confronto diretto e onesto. Non si tratta di tecnicismi per specialisti, ma di richieste da rispettare per venire incontro alle esigenze di ogni portatore d’interesse: ricercatori, decisori, imprenditori, cittadini. Ciò vale a maggior ragione quando sono impiegate risorse pubbliche (nella fattispecie fondi, strutture, personale) e quando gli effetti possono riguardare anche chi non è coinvolto direttamente, come colture che, non protette in modo adeguato, rappresentano un potenziale serbatoio di agenti patogeni per il territorio.
In conclusione, l’Institut Agricole Régional e la Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS evidenziano insieme quanto sia importante mantenere un’attenzione elevata, critica e consapevole verso il ruolo della ricerca scientifica e delle applicazioni tecnologiche nella società contemporanea, sempre più complessa e interconnessa: è il concetto di “cittadinanza scientifica” invocato, tra gli altri, da Pietro Greco (1955-2020), giornalista e studioso di comunicazione della scienza. La cultura scientifica non appartiene a nessuno, perciò viene resa pubblica attraverso le riviste specializzate, gli atti dei congressi, i saggi in volume, i database e le repository online. Informarsi e informare sui temi di scienza e tecnologia è diritto e allo stesso tempo dovere di ognuno, altrimenti si rischia di non essere in grado di partecipare in maniera responsabile al processo democratico, venendone estromessi.
Nus/Aosta, 4 settembre 2025
Jean Marc Christille, Direttore della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS
Piero Prola, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e Mauro Bassignana, Direttore della Sperimentazione dell’Institut Agricole Régional