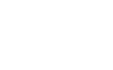Progetto Cosmologia
Il Progetto Cosmologia consiste in differenti progetti di ricerca impegnati nello studio delle componenti che descrivono l’universo nella sua globalità: energia oscura e materia oscura; teorie di gravità modificata; onde gravitazionali.
Euclid e l’universo oscuro
L’acquisizione graduale nello staff dell’OAVdA del dott. Matteo Calabrese, PhD, del dott. Lorenzo Pizzuti, PhD, entrambi ricercatori, e infine del dott. Stefano Sartor, tecnologo, ha permesso di costituire un gruppo di ricerca di cosmologia teorica e osservativa, ovvero la disciplina che studia l’universo nel suo insieme, sia dal punto di vista ‘geografico’ della distribuzione di materia e energia nello spazio, sia da quello ‘storico’ della sua evoluzione nel tempo. Il management scientifico del Progetto Cosmologia è assunto in prima persona dal dott. Jean Marc Christille, PhD, Direttore della Fondazione Clément Fillietroz-ONLUS; le sue attività da anni sono sostenute anche da erogazioni ordinarie per il bando “Ricerca & Istruzione” della Fondazione CRT-Cassa di Risparmio di Torino.
Matteo Calabrese rappresenta l’OAVdA nel gruppo di lavoro CMBXC-SWG (acronimo di Cosmic Microwave Background Cross-correlation Science Working Group) della missione Euclid dell’agenzia spaziale europea ESA. Complessivamente in Euclid sono coinvolti oltre trecento scienziati italiani di INAF, INFN e numerose università. Euclid è una delle più importanti missioni di ESA, inserita nel programma decennale Cosmic Visions 2015-2025. Ha come obiettivo lo studio della materia oscura e dell’energia oscura. Questi due misteriosi componenti sembrano costituire rispettivamente circa il 27% e il 68% dell’universo osservabile, mentre la materia e l’energia di cui abbiamo esperienza quotidianamente formerebbe poco meno del 5% del cosmo.

La sonda Euclid negli stabilimenti dell’azienda aerospaziale italo-francese Thales Alenia Space, a Cannes. Credit: ESA – Manuel Pedoussaut
Il telescopio da 1,2 m di apertura di Euclid raccoglierà luce alle lunghezze d’onda del visibile e del vicino infrarosso, osservando oggetti cosmici distanti fino a 10 miliardi di anni luce. A bordo ha due strumenti che lavorano in parallelo: VIS (Visible Instrument) e NISP (Near Infrared Spectrometer and Photometer). In questo modo sarà possibile studiare le caratteristiche morfologiche e spettroscopiche di decine di milioni di galassie.
LISA e le onde gravitazionali
La missione spaziale dell’ESA LISA (acronimo per Laser Interferometer Space Antenna) è attualmente in fase di progettazione e con data di lancio prevista per il 2034. La missione sarà composta da tre satelliti artificiali che orbiteranno in formazione attorno al Sole formando un triangolo equilatero di circa 2,5 milioni di km di lato. Grazie a raggi laser che si scambieranno tra loro, i tre satelliti formeranno un interferometro nello spazio, sensibile ai più piccoli cambiamenti di distanza tra i tre corpi dovuti al passaggio di onde gravitazionali.
Lo scopo della missione è rivelare le onde gravitazionali generate da sistemi di stelle binarie all’interno della nostra galassia, da buchi neri supermassicci in altre galassie, dalla fusione tra buchi neri. Non affetta dai disturbi ambientali di origine terrestre, LISA potrà esplorare frequenze molto più basse di quelle a cui sono sensibili gli interferometri come Virgo e LIGO, che pure hanno permesso le scoperte premiate con il Nobel per la fisica nel 2017.
Anche per LISA l’OAVdA è rappresentato nel consorzio scientifico da Matteo Calabrese in quanto associato al gruppo di lavoro Cosmology-WG attraverso il nodo di Milano, referente la dott.ssa Carmelita Carbone, ricercatrice dell’INAF-Osservatorio Astronomico di Brera, dell’INAF-Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica cosmica e dell’Università degli Studi di Milano.
STRIP e la radiazione cosmica di fondo
Stefano Sartor, tecnologo all’OAVdA da settembre 2019, contribuisce anche alla realizzazione del polarimetro STRIP (Survey TeneRIfe Polarimeter), che fa parte del Progetto LSPE (Large-Scale Polarization Explorer), finanziato dall’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e dall’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) e di cui è responsabile scientifico il prof. Paolo de Bernardis, della Sapienza Università di Roma, tra i maggiori cosmologi osservativi del nostro Paese.
LSPE misurerà su vaste scale angolari la polarizzazione della CMB, ovvero la radiazione cosmica di fondo che permea l’intero cosmo e reca traccia dei processi avvenuti nelle prime fasi di storia dell’universo. Per realizzare questo obiettivo, la collaborazione internazionale si avvarrà di due strumenti: SWIPE (Short Wavelength Instrument for the Polarization Explorer), un polarimetro sensibile a frequenze superiori a 100 GHz che, lanciato dall’arcipelago norvegese delle isole Svalbard, volerà sollevato da un pallone stratosferico durante la stagione invernale al circolo polare artico; poi il già citato STRIP, polarimetro invece sensibile a frequenze inferiori a 100 GHz che osserverà il cielo dall’arcipelago spagnolo delle isole Canarie.
Guarda il video della Conferenza di stagione – Autunno 2022 “L’UNIVERSO IN SCATOLA – modelli teorici e dati osservativi nella cosmologia contemporanea”, trasmessa online giovedì 15 dicembre 2022.